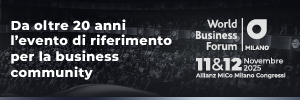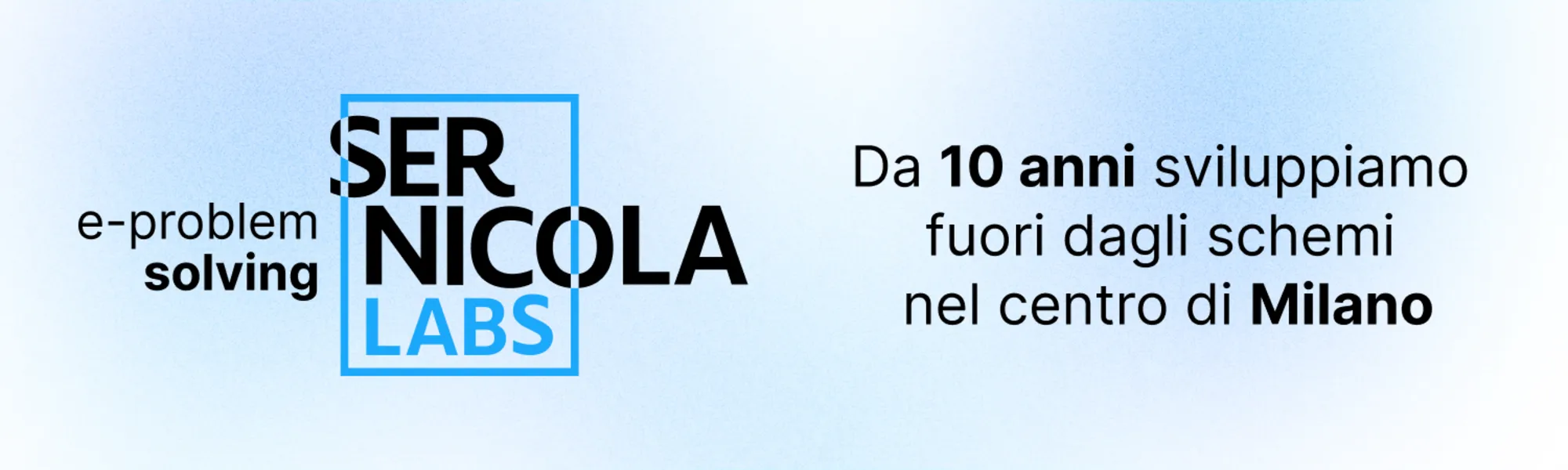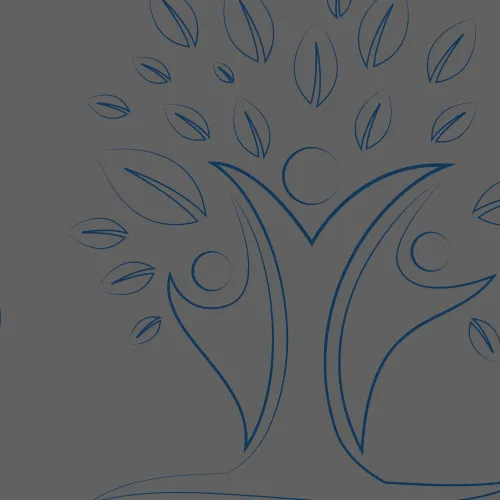Il processo decisionale nell’era dell’imprevedibile

Le profonde trasformazioni e la fine dei “grandi racconti”
Nel nuovo scenario, siamo di fronte a modelli organizzativi che dall’inizio degli Anni 2000 contribuiscono a delineare una situazione di crisi ricorsiva. Infatti, a riscontro di quanto qui sostenuto, nel nostro futuro si pone un’importante questione di governance delle organizzazioni e una ridefinizione della configurazione del sistema economico, verso una prospettiva di oversizing aziendale, di innovazione continua, di una maggiore responsabilità sociale e un più alto grado di sostenibilità eco-ambientale.
A questo riguardo, come rileva Butera, in merito alle esperienze di best practice aziendali nel panorama nazionale (2020): “Le imprese italiane migliori, da noi studiate nel programma Italian way of doing industry, hanno affrontato la crisi continuando incessantemente a innovare i loro prodotti e servizi, il posizionamento di mercato, le strategie, il business model, i processi, la governance, il dimensionamento, l’organizzazione macro e micro, la tecnologia, le competenze e soprattutto la loro identità. Esse sono nate piccole e sono cresciute internazionalizzandosi”.
In questo quadro concettuale, che mette in discussione e ribalta finalità, spazi e tempi dell’agire strategico e organizzativo, come osserva acutamente il sociologo Zygmunt Bauman (2002): “È probabile che il desiderio di Rockefeller fosse quello di costruire immense fabbriche, strade ferrate e oleodotti e possederli il più a lungo possibile (per l’eternità, se si misura il tempo in base alla durata della vita di un uomo o di una famiglia). Bill Gates, viceversa, non ha alcuna remora a staccarsi da quanto aveva creato con tanto orgoglio il giorno prima; oggi è la pazzesca velocità di circolazione, di riciclaggio, di obsolescenza, di smaltimento e sostituzione che crea profitto”.
Si assiste, dunque, a un considerevole mutamento della nostra società, un fenomeno che il filosofo francese Jean-François Lyotard spiega introducendo il concetto di “postmoderno”, nel saggio La condition postmoderne (1979), in cui sostiene che l’età contemporanea ha raggiunto il suo termine con la delegittimazione dei “grandi racconti” (grands récits), ovvero delle prospettive filosofiche e ideologiche che, a partire dall’Illuminismo, hanno ispirato e condizionato le credenze e i valori della cultura occidentale orientati al progresso continuo, fenomeno oggi interessato da una crisi strutturale, ma soprattutto di carattere culturale.
In questa prospettiva, l’età postmoderna non è più legata all’elaborazione di grandi progetti, frutto di una vision ‘capace di guardare lontano’, ma si caratterizza piuttosto per una pluralità di azioni la cui validità è solo strumentale e contingente, con un atteggiamento che spesso rischia di dare risposte pragmatiche e non sistematiche ai problemi della persona, delle imprese, delle istituzioni e della società.
Una condizione che non ha permesso e non permette di governare adeguatamente l’estrema pervasività dell’innovazione tecnologica e organizzativa e che s’impone attraverso una serie di fenomeni particolarmente innovativi, come: la digitalizzazione dei processi; la diffusione di Internet of things e la sua applicazione ai processi produttivi, alla logistica, all’infomobilità, all’assistenza remota, all’ottimizzazione energetica e alla tutela ambientale; le potenzialità insite nella sperimentazione di nuovi materiali e l’impatto sui processi produttivi; il ricorso alla robotica e alla stampa 3D, dai processi produttivi alla telemedicina; l’estensione di sistemi di video comunicazione 5G attraverso l’iCloud e una serie di device di nuova generazione; il ricorso all’Intelligenza Artificiale (AI) e l’impiego di Big data in contesti produttivi, di studio e ricerca.
Del resto, in questo panorama caratterizzato da un’inarrestabile innovazione tecnologica e un diffuso sviluppo applicativo dell’AI, come si chiede lo scrittore Byron Reese (2019): “La tecnologia sarà al servizio del nostro benessere, del progresso scientifico, economico e civile, così come è sempre stato nel corso della nostra storia? Oppure finiremo per ‘disumanizzarci’?“.
Una metamorfosi inattesa
In linea con questa prospettiva si potrebbe sostenere che siamo di fronte a un profondo bouleversement, una sorta di sconvolgimento, che il sociologo e scrittore Ulrich Beck (2017) definisce come un processo di metamorfosi. Infatti, lo studioso tedesco ricorda che il nostro mondo è attraversato proprio da un vero processo di metamorfosi: non è cambiamento sociale, non è trasformazione, non è evoluzione, non è rivoluzione, non è solo discontinuità, non è crisi.
La metamorfosi è una modalità di cambiamento della natura dell’esistenza umana. Chiama in causa il nostro modo di essere nel mondo. È innegabile che viviamo in un mondo sempre più difficile da decodificare. Non sta semplicemente cambiando: è in metamorfosi. Ciò che prima veniva escluso a priori, perché totalmente inconcepibile, accade. Sono eventi globali che passano generalmente inosservati e si affermano, al di là della sfera della politica e della democrazia, come effetti secondari di una radicale modernizzazione tecnica ed economica.
In realtà, stiamo assistendo a una profonda trasformazione dei mercati internazionali, della stessa divisione del lavoro e della conseguente ridistribuzione di ruoli interpretati dai vari player. Sul mercato globale non competono più beni/servizi o imprese, bensì i sistemi Paese. Essi competono tra di loro, non più e non solo sulla base dell’andamento degli indicatori economici, ma soprattutto in relazione alla capacità di ‘saper fare sistema’, di creare una cultura aperta e una rete di alleanze, in modo tale da poter disporre di positivi interscambi a livello internazionale e globale.
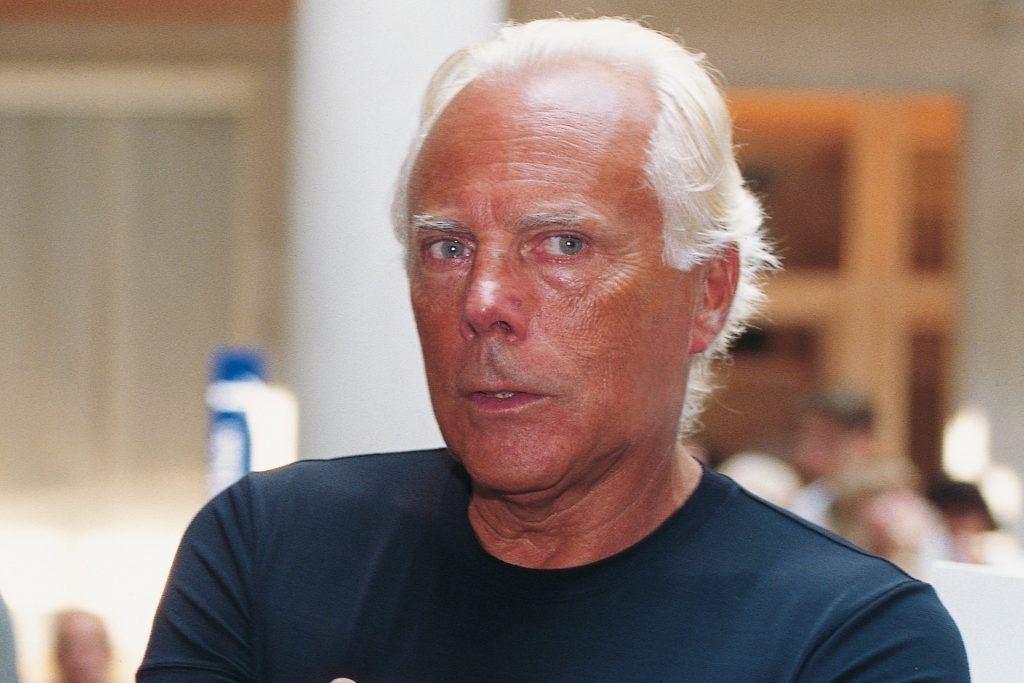
Addio a Giorgio Armani, Re della moda

Turani, l’ex Direttore Editoriale della ESTE nel Famedio di Milano

ESTE+, la nuova dimensione della crescita professionale