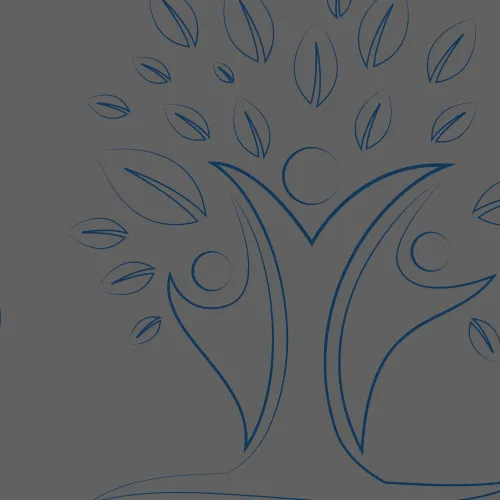Il lavoro decente come antidoto alla società individualista

L’8 novembre 2025 la Chiesa ha celebrato il Giubileo del Lavoro. “Deve essere una fonte di speranza e vita, che permetta di esprimere la creatività dell’individuo e la sua capacità di fare del bene”, ha detto Papa Leone XIV ai pellegrini nel corso dell’udienza indetta per l’occasione. Parole che rievocano il valore della principale attività umana, spesso calpestato, come talvolta ricordano dati economici e cronaca.
Disoccupazione giovanile, bassi salari, precarietà: i problemi nel mondo del lavoro – in Italia e non solo – non mancano di certo. A causarli è forse una visione erronea. “Oggi il concetto di ‘lavoro giusto’ ha messo in ombra un’altra dimensione”, sottolinea Stefano Zamagni, classe 1943. Tra i ruoli che ha ricoperto c’è quello di Presidente dell’Agenzia per il Terzo settore e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Oggi è docente di Economia Politica all’Università di Bologna, tuttora in servizio nonostante la pensione.
Qual è l’altro aspetto del lavoro che stiamo perdendo?
Ci sono due dimensioni, l’estrattiva e l’espressiva. La prima dice che chi lavora ottiene un potere d’acquisto attraverso cui soddisfare le proprie necessità. A questa fa riscontro il concetto di ‘lavoro giusto’, che consente alle persone appunto di sostentarsi. Ma c’è un’altra nozione che sta sfumando, ed è quella di lavoro decente.
Un concetto che sembra aleggiare anche nelle parole del Papa. Che cosa s’intende?
Di mezzo c’è la dimensione espressiva del lavoro. Noi umani esprimiamo i nostri talenti con il lavoro e per mezzo del lavoro. È questo il ‘lavoro decente’, idea riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale del lavoro. Ma in Italia non se ne parla mai, è un limite culturale anche dei movimenti sindacali e delle imprese quello di pensare solo alla parte remunerativa.
Che in Italia continua a essere una questione irrisolta perché gli stipendi sono fermi…
Una cosa non esclude l’altra. Io ti pago alla fine del mese, ma non basta. Perché è un’umiliazione se poi non consento la tua fioritura. È necessario voltare pagina su questo piano. Do per scontato che il lavoro debba essere giusto. Specie in passato si insisteva su questo e penso all’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1890: ma allora esistevano ancora forme di schiavitù ignobili. I salari sono repressi e su quel fronte la battaglia deve continuare. Però, proseguire solo in quella direzione non può che sollevare perplessità.
Viene da pensare anche al tema sicurezza: di recente a Roma c’è stata l’ennesima morte bianca…
La questione suscita vergogna perché oggi ci sarebbe il modo di evitare certe tragedie. Non come una volta. La memoria va alla costruzione del Canale di Suez, durante la quale morirono milioni di operai. Le vicende recenti fanno tornare ancora una volta a quanto già detto: la persona è umiliata, non ne è valorizzato il talento. E così si lascia andare.
Ci spieghi meglio.
Se c’è l’obbligo di mettere il casco, faccio questo esempio, il lavoratore non lo rispetta. Non lo indossa perché è avvilito, sente di vivere una condizione di solitudine esistenziale. Come quelli che non si curano pur avendo un sistema sanitario che potrebbe assisterli, così il lavoratore frustrato – e sottolineo di nuovo il concetto di lavoro decente – tende a mettere in sottordine queste precauzioni. Quando si perde il senso della vita non si dà rilevanza a ciò che merita attenzione.
Non crede che sia tutta la società ad aver perso di vista i valori essenziali?
Circola una cultura che aderisce a un materialismo diverso da quello storico marxiano, di tipo neoliberista che è peggiore di quello tradizionale. La gente non lo sa, ma il neoliberismo è una deviazione del liberalismo, l’esaltazione di tutto ciò che è materialistico. Il pericolo sta nella sottomissione della dimensione spirituale dell’essere umano. Che non ha solo a che vedere con la religione, perché esiste anche in chi non ha fede. Papa Francesco parlava di “scarti umani” in riferimento ai più deboli e agli emarginati. Il senso era che l’uomo non può essere ridotto solo a materia, buttata via come un pezzo di carne avariato.
I giovani sembrano risentirne particolarmente: perché sono centinaia di migliaia quelli che abbandonano l’Italia e vanno in cerca di fortuna altrove?
Bisognerebbe aprire un dibattito sulle cause profonde del perché questo avviene. Non basta descrivere il disagio giovanile. Troppi intellettuali superficiali si limitano a quello. C’è un consumo di psicofarmaci raddoppiato tra i giovani. Dalla fine del secondo scorso si è diffuso il singolarismo, nato in California come estremizzazione dell’individualismo, che nasce con la Rivoluzione francese e l’Illuminismo. Ed è opposto al comunitarismo.
I giovani se ne fanno portavoce?
Per loro significa recidere ogni legame con un gruppo a cui si è appartenuto, famiglia e affetti. E si pensa che così si afferma una identità e si valorizza il potenziale di vita. Ma attenzione: l’individuo è al centro in quanto parte di qualcosa e membro di qualche comunità di riferimento. Si fa credere che ognuno sia artefice del proprio destino, quando invece nessuno può farcela da solo.
Qual è il messaggio da dare?
Gran parte dei bisogni si devono soddisfare nella relazione interpersonale. Lo dico ai miei studenti: devono aiutarsi l’un l’altro. Al contrario di quello che si propina oggi quando si diffonde la convinzione che ciò di cui si ha bisogno si compra sul mercato. Così ci si deprime, c’è chi finisce nella droga, chi nella violenza. Sono gli effetti della cultura singolarista.
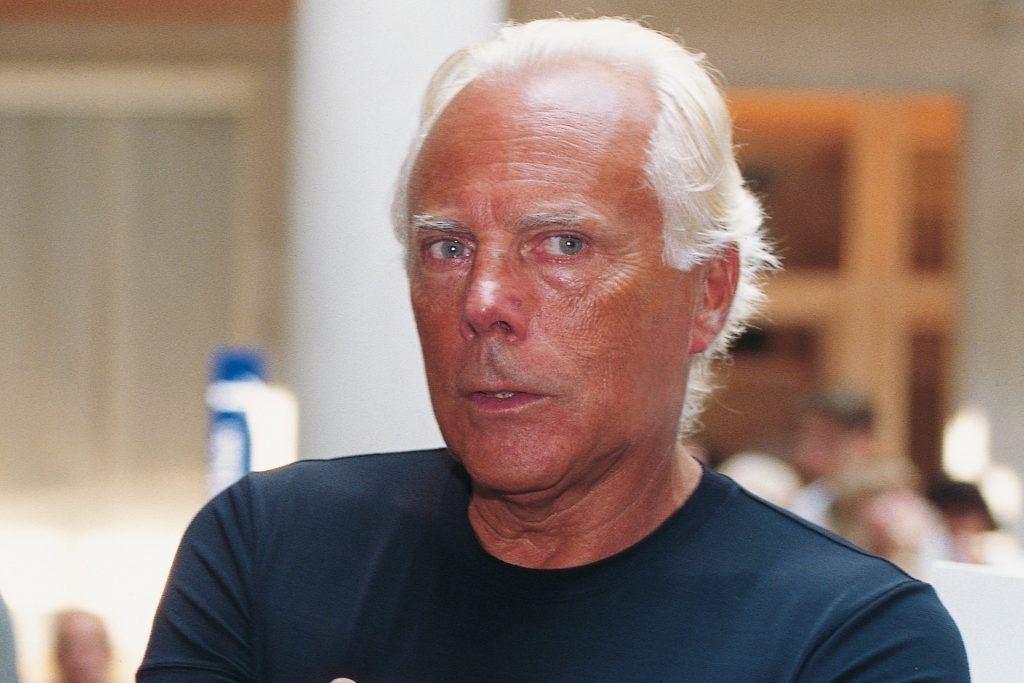
Addio a Giorgio Armani, Re della moda

Turani, l’ex Direttore Editoriale della ESTE nel Famedio di Milano

ESTE+, la nuova dimensione della crescita professionale