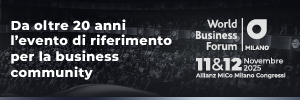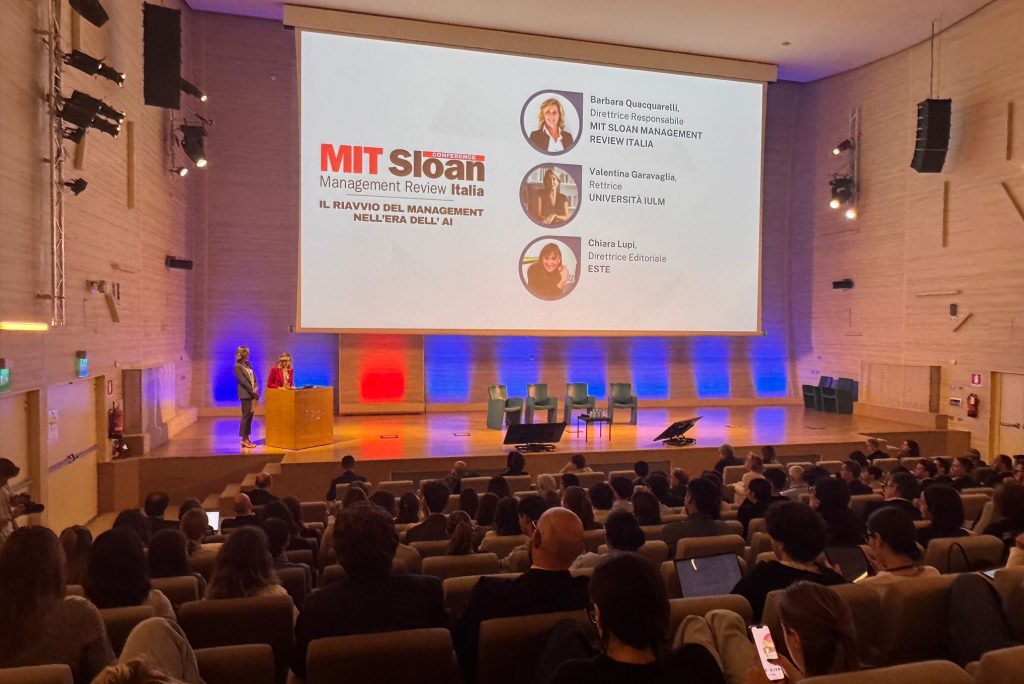Clint Eastwood e il principio di responsabilità
Il nuovo film di Clint Eastwood, Giurato numero 2, tematizza uno snodo critico della nostra società, il principio di responsabilità. La trama del film è semplice, ma intrigante. L’attore Nicholas Hoult è Justin Kemp, chiamato a fare parte di una giuria per un caso di omicidio. Questo giovane uomo ha le migliori intenzioni e intende esercitare il suo ruolo responsabilmente. Tuttavia, la sua condizione è un po’ più complessa: ha un passato da alcolizzato, da cui è uscito con un programma di recupero; è stato aiutato dalla moglie Ally (Zoey Deutch) e con lei sta per avere una bambina; deve far fronte alla comprensibile ansia alimentata per Ally dall’idea che il protrarsi del giudizio in camera di consiglio la privi del supporto del marito nelle ore del parto, ormai vicino.
Le prime scene del film sono altamente simboliche e caricano di tensione l’attesa per quanto accadrà: compare la dea della giustizia, bendata, con la bilancia in mano; è bendata anche la sposa, che Justin conduce a esplorare la sorpresa dell’allestimento per la camera del figlio; ma questa benda cade. Poi quando Ally esce dalla stanza, inavvertitamente spegne la luce e lascia il marito al buio. Gli eventi si sviluppano rapidamente, con ritmo intenso. Si svolgono i riti del procedimento giudiziario, a partire dalle fasi di selezione dei giurati con le verifiche necessarie, poi l’insediamento della giuria; e si arriva subito all’avvio del processo, con accusa e difesa che espongono le rispettive posizioni. L’imputato James Michael Sythe, con precedenti in una banda di quartiere, è accusato di avere ucciso la compagna Kendall Carter, trovata abbandonata in un fosso al margine di una strada, dopo che i due erano stati visti litigare furiosamente in un locale.
Eastwood contro Lumet
Con queste premesse, l’approccio dei dodici giurati in sala consiglio sembra riprodurre le prime sequenze del classico La parola ai giurati (12 angry men) di Sidney Lumet: il caso sembra chiaro, anche se è un processo indiziario. Non si vedono possibili colpevoli diversi dall’imputato, ma in grande maggioranza i giurati sono sbrigativi e superficiali, alcuni proiettano sull’accusato le rabbie del proprio vissuto. Nel film di Lumet (1957) la giuria rispecchia una società patriarcale, culturalmente arretrata; sono tutti maschi, bianchi, apparentemente omogenei; solo uno di loro, l’architetto impersonato da Henry Fonda, si oppone al giudizio sommario, invita alla riflessione nell’ottica del ‘ragionevole dubbio’. Alla fine, si rivelerà persuasivo, capace di riorientare la situazione, facendo emergere che l’omogeneità dei giurati esiste solo in superficie. Il nuovo film invece riflette una società americana molto differente: sono passati più di 60 anni, tra i 12 ci sono donne e persone di colore, la selezione dei giurati è filtrata con rigore da accusa e difesa, oltre che dal giudice. Eppure, la superficialità è la stessa, persino meno dignitosa, espressa da alcuni con maggiore arroganza.
Sembrerebbe che proprio a Justin Kemp tocchi di replicare Henry Fonda: è lui a essere perplesso sull’atteggiamento sbrigativo dei colleghi; è lui che vuole essere responsabile, approfondire una vicenda che presenta lati oscuri; è lui che cerca di fare opera di persuasione nel segno del ragionevole dubbio. Il problema di Justin è che presto si rende conto di avere lui stesso causato la morte di Kendall Carter: era presente in quel bar, quella sera, anche se aveva resistito alla tentazione di bere. Nel ritorno a casa, nella notte, sotto un temporale terribile, aveva investito qualcosa, pensava un cervo, ma durante lo svolgimento del processo capisce che quasi sicuramente si trattava della donna.
Quindi non è più un giurato alle prese con il ragionevole dubbio e con il proprio senso di responsabilità, come Henry Fonda; ma è il detentore di un’informazione che può scagionare l’imputato, a patto di assumersi la colpa. La responsabilità non è più una generica istanza cui si può corrispondere senza costi particolari, ma anzi gratificando la propria autostima di difensore disinteressato di chi è più debole, di quasi eroe in un evento giudiziario. La responsabilità diventa una chiamata in causa di sé, del destino proprio e della propria famiglia, con la figlia in arrivo. Un tragico dilemma morale.
La difficile applicazione del principio di responsabilità
Clint Eastwood scopre le carte fin dalle scene iniziali; non c’è suspense sulla natura dell’evento, su chi sia colpevole o innocente: la tensione è tutta sulla scelta di Kemp. Potrebbe autodenunciarsi, liberando un innocente da una condanna ingiusta. In questo caso pogherebbe un prezzo elevato, perché quel tipo di omicidio colposo, dati i suoi precedenti, sarebbe gravemente punito. Oppure può fare finta di nulla, avallando la condanna del malcapitato e accettando di commettere una grave ingiustizia. Una via intermedia è quella di fare di tutto per assolvere l’imputato senza rivelare la verità dei fatti.
Se la situazione appare semplice, l’applicazione del principio di responsabilità lo è meno. Philip Selznick ci offre una traccia, nel suo magistrale studio sulla moralità nella modernità. Il regista americano ci porta ben dentro questi dilemmi; l’individuo non è isolato nell’esercizio della responsabilità; è inserito nelle vicende che hanno dato e danno forma alla sua identità, in un tessuto relazionale e di norme sociali, in un incrocio di aspettative e istanze contrastanti.
La filmografia di Clint Eastwood è ricca di personaggi il cui senso di responsabilità privilegia l’integrità nel senso di autonomia di giudizio, anche violando leggi e regole, come il protagonista di Million Dollar Baby, logiche di convenienza, come Richard Jewell, o persino i propri pregiudizi, come l’anziano pensionato di Gran Torino. O ancora come i tre protagonisti di Hereafter, animati dalla ricerca intensa ed energica di vita autentica, liberata dagli schemi e dai vincoli sociali che li hanno inizialmente condizionati. Costoro si comportano come ritengono appropriato, al di là di regole sociali o di un’etica delle conseguenze. La giustizia per Clint non è quella delle istituzioni, che possono solo fallire pretendendo di regolare i mille casi particolari della vita. In questa nuova opera va ancora oltre, insinuando il seme del dubbio ben dentro i meccanismi del sistema giudiziario.
Il ragionevole dubbio è anche nel management
Tutto il resto del film è sul dilemma, irrisolto o irrisolvibile, che imprigiona la figura di Justin Kemp. Lui è drammaticamente solo, ma al tempo stesso inserito in un sistema complesso, nel cui ambito altri personaggi esprimono una propria autonomia ed escono anche dai ruoli stabiliti, privilegiando una logica di appropriatezza. È il caso innanzitutto di Faith Killebrew (Toni Colette), pubblico ministero: sembra irrigidita all’inizio nella sua posizione formale (vedasi la dichiarazione iniziale: “Questo sistema, per quanto imperfetto, è la nostra migliore possibilità di trovare una giustizia”) e condizionata dall’interesse personale, in quanto impegnata in una competizione elettorale; ma poi si prende a cuore la ricerca della verità con comportamenti proattivi e inattesi.
Responsabile in questo stesso senso è anche uno dei giurati, l’ex detective Harold (J.K. Simmons), portato dalla sua esperienza pregressa a contraddire i referti della polizia, fino a uscire dai binari che regolano e limitano la sua funzione. Altri componenti della giuria escono da questi binari, come l’educatore che riconosce nel tatuaggio dell’imputato l’emblema della gang di cui è stato vittima il fratello, o la donna che ha nel mirino il maschilismo; è difficile però leggere i loro comportamenti in chiave di responsabilità, perché manipolano le prerogative del ruolo attribuito per affermare una pretesa di giustizia senza vaglio critico né gestione degli impulsi passionali. Nel bene e nel male, le persone portano il loro vissuto, i propri sentimenti, la rispettiva visione del mondo nei ruoli istituzionali cui pro tempore assolvono. Il principio di responsabilità si perde nei meandri del sistema giudiziario, che dovrebbe presidiare proprio questo; magari riemerge, per vie inaspettate, fuori degli schemi e delle regole, per spinte volontariste di singole persone.
Si può non condividere la sfiducia di Clint Eastwood nelle istituzioni sociali e ancor di più nel sistema giudiziario. Per una teorizzazione che collochi la responsabilità individuale nel più ampio contesto organizzativo e istituzionale dobbiamo rivolgerci ad altri e qui Philip Selznick può essere un riferimento importante. Ma questo film ha la potenzialità di innescare un ‘ragionevole dubbio’ anche rispetto a costrutti e pratiche dell’organizzazione e del management, in un tempo che vede l’impersonalità e rigidità delle regole ormai obsolete davanti ai livelli raggiunti dalla complessità sociale e dalla variabilità dei comportamenti soggettivi.
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)
responsabilità, management, Clint Eastwood, giurato, nicholas hoult