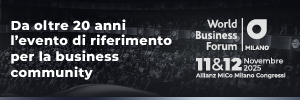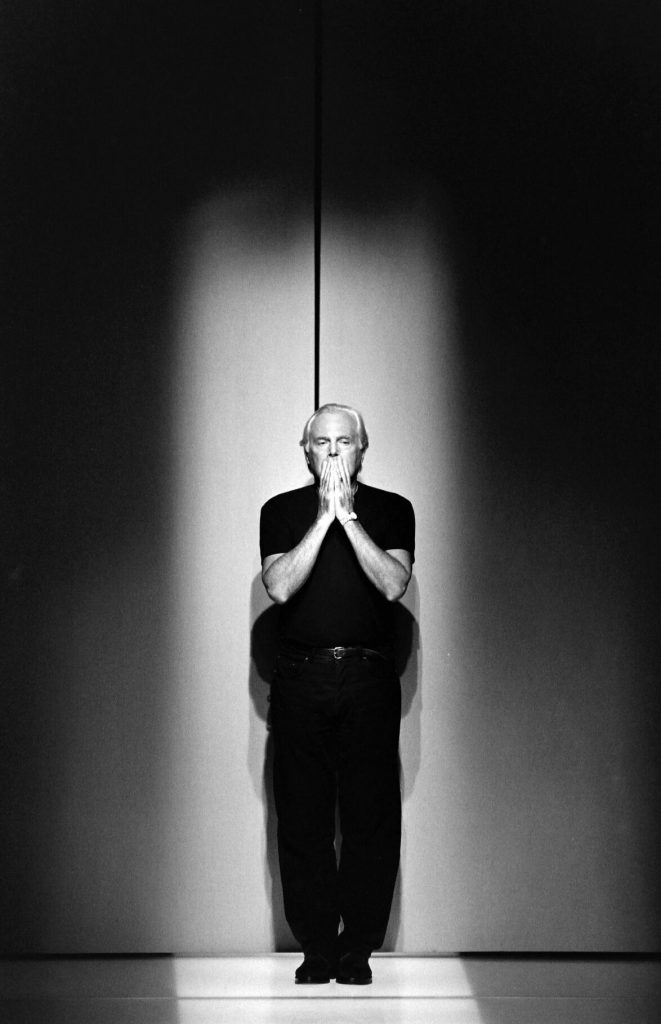Dazi, quali effetti per il Made in Italy?
Il recente accordo tra Usa e Unione europea sui dazi merita un’analisi ampia, che trova un ancoraggio nella teoria economica. Quest’ultima dà spesso per scontato che, come teorizzato da John Stuart Mill, il soggetto dell’attività economica sia l’homo oeconomicus, “un individuo astratto, del cui agire nella complessa realtà sociale si colgono solo le motivazioni economiche, legate alla massimizzazione della ricchezza”. L’homo oeconomicus, pertanto, è un individuo che massimizza il proprio benessere impiegando le sue risorse finanziarie per i beni e servizi che gli risultano più utili: in tale logica, è il ‘valore d’uso’ (cioè l’utilità percepita dall’acquirente) a influenzare il ‘valore di scambio’ (in definitiva, il prezzo riconosciuto al venditore): se fa più freddo, il valore d’uso del gas aumenta, e ciò – attraverso l’incontro di domanda e offerta – ne fa aumentare il prezzo (a parità di altre condizioni).
In realtà, come ha rilevato Daniel Kahneman con i suoi studi di economia cognitiva (che gli hanno valso il premio Nobel), i comportamenti umani sono meno linearmente razionali (Herbert Simon, anch’egli premio Nobel, aveva parlato di “razionalità limitata”), ma comunque orientati a logiche di tentata massimizzazione dell’utilità percepita, che continuano a mettere in relazione il valore di scambio (cioè il prezzo) con un valore d’uso in qualche modo più o meno ampiamente riconosciuto (anche se in misura soggettivamente differenziata).
Certo, oggi assistiamo a situazioni in cui l’homo appare sempre meno razionalmente oeconomicus: si consideri, come esempio limite, ciò che è avvenuto per la quotazione della famosa banana di Maurizio Cattelan, pagata 6,2 milioni di dollari dall’imprenditore cinese Justin Sun, che poi, semplicemente, l’ha mangiata; situazioni queste che fanno dubitare della sussistenza del benché minimo rapporto tra prezzo (oggettivo) e utilità (soggettiva) dell’oggetto transato. E discorsi analoghi potrebbero essere probabilmente fatti per le criptovalute, dal Bitcoin al $Trump, strumenti speculativi che – contrariamente alle azioni, all’oro o alle valute a corso legale – non hanno alcun valore se non quello più o meno convenzionalmente (e provvisoriamente) attribuitogli dai rispettivi investitori.
Una guerra commerciale geopolitica
Nella ‘normale’ economia globalizzata, sono i mercati che determinano la formazione dei prezzi (valori di scambio) per beni e servizi i cui valori d’uso sono universalmente riconosciuti, anche se in misure soggettivamente articolate (l’utilità potenziale di un bene non è la stessa per tutti): posso non aver bisogno di una tonnellata di rame o di un’auto elettrica, ma sono consapevole che, avendoli, li potrei scambiare facilmente a condizioni di mercato la cui razionalità è garantita dalla stabilità strutturale delle relative domande e offerte.
I dazi obbediscono (o, meglio, dovrebbero obbedire) a questa logica: se l’offerta di prodotti cinesi è superiore a quella degli omologhi europei a causa dei differenti costi dei rispettivi fattori di produzione (in primis, il lavoro), i dazi imposti dall’Ue hanno (o dovrebbero avere) lo scopo di livellare, ed equilibrare, le condizioni di concorrenza, cercando di contemperare i vantaggi cumulativi del commercio internazionale (che aumenta la produzione complessiva di ricchezza) con la protezione dei legittimi interessi dei produttori locali, ancora una volta ricercando ragionevoli relazioni tra i rispettivi valori d’uso e di scambio. La World trade organization (Wto), ha (o meglio dovrebbe avere, vista la sua attuale marginalizzazione di fatto) il non facile compito di cercare di regolare tali dazi (quando ritenuti inevitabili) attraverso accordi internazionali, per evitare che eccessi (reali o percepiti) di interventi protezionistici sfocino in guerre commerciali che, inevitabilmente, danneggiano tutti gli interessati.
Gli interventi sul tema dazi del Presidente Usa Donald Trump, con il susseguirsi di imprevedibili ‘colpi di teatro’, sono sembrati però orientati da logiche più geopolitiche (e ancor più populisticamente indirizzate al proprio elettorato) che razionalmente commerciali, mettendone in discussione i princìpi di razionalità economica: all’homo oeconomicus si sostituisce così l’homo politicus? Non a caso, il Wall Street Journal ha definito l’insieme delle manovre – fin dal loro primo annuncio – “la più stupida guerra commerciale della storia”, anche perché prospettava trattamenti tariffari particolarmente aggressivi nei confronti di Canada, Messico e Ue, storici alleati.
Per citare lo storico Bernard Lewis, ancora una volta: “È rischioso essere il nemico dell’America, ma può essere fatale essere suo amico”. In realtà, le successive evoluzioni dai primi annunci di Trump sui dazi avevano visto, prima dell’accordo con Bruxelles delle tariffe al 15%, la parziale sospensione, ‘compensata’ dall’escalation della guerra commerciale con la Cina, anche questa portata avanti in termini estremamente contradditori (cellulari e computer prima condannati a tassazioni insostenibili e poi ‘graziati’).
A conferma dell’illogicità di molte delle scelte operate da Trump c’è da registrare il conseguente rafforzamento del dollaro rispetto alle altre valute, mentre ogni politica tendente a riequilibrare una bilancia commerciale troppo negativa (obiettivo dichiarato della manovra) dovrebbe tendere a una sua relativa svalutazione (politica questa molto praticata dell’Italia nei decenni precedenti l’introduzione della moneta unica europea).
Le ricadute sull’Italia
Come impatterà tutto ciò sul nostro sistema produttivo? Sicuramente i dazi comportano un ostacolo alle esportazioni che però può – in alcuni casi – essere almeno parzialmente compensato da un aumento della domanda interna. Agli effetti pratici per la singola impresa, tuttavia, la loro caratteristica più influente è l’ampia differenziazione in base alla tipologia dei prodotti e dei relativi mercati, che spaziano in un vasto range che va dalla concorrenza (più o meno perfetta) alla concorrenza monopolistica più differenziata.
Infatti, nel caso delle commodity – beni standardizzati realizzati da numerosi produttori in competizione (per esempio: le lamiere e i profilati in acciaio) – l’imposizione dei dazi comporta un pressocché pari aumento del prezzo di vendita, difficilmente assorbibile da aziende di solito caratterizzate da margini percentualmente molto ridotti, e tale spesso da escludere le imprese colpite dai mercati nazionali che, così, si proteggono.
La situazione è molto diversa, invece, per i prodotti trattati in mercati nei quali la concorrenza è altamente monopolistica, sia per ragioni tecnologiche (si pensi, per esempio, all’elevata fidelizzazione dei clienti Apple, relativamente poco sensibili a ragionevoli aumenti di prezzo) sia per le caratteristiche posizionali dei beni trattati, per i quali – paradossalmente – prezzi elevati costituiscono fattori di preferenza, proprio in quanto relativi a consumi ostentativi, connotanti la collocazione sociale dell’acquirente (i clienti di autovetture Ferrari o di borse Prada difficilmente saranno dissuasi dall’acquisto a seguito dell’applicazione di un dazio che ne aumenta i prezzi d’acquisto).
Per tutti i prodotti (e sono la maggior parte) che si collocano in posizione intermedia tra le commodity e i beni posizionali, risulta comunque confermato il vantaggio competitivo che si persegue ogni volta in cui, per innovazione tecnologica e/o merceologica, caratterizzazione di design e personalizzazione di prodotto e/o di servizio post vendita, si conferiscono caratteristiche di ‘unicità’ al prodotto stesso: ancora una volta il Made in Italy può essere un fattore vincente nel confronto concorrenziale, indipendentemente dall’introduzione o meno di vincoli tariffari tendenti a limitare i flussi commerciali verso, o da, singoli mercati nazionali. È questo uno dei pochi elementi di certezza sui quali possiamo contare in un contesto globale sempre meno prevedibile.
Ingegnere, è Professore Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale presso il Politecnico di Bari, del quale è stato Rettore dal 2009 al 2013. Autore di circa 300 pubblicazioni a carattere internazionale e nazionale, prevalentemente sui temi del Supply chain management e del Construction management, ha svolto attività di ricerca e didattica in Usa, Regno Unito, Danimarca, Spagna, Cina. In qualità di Direttore Tecnico di una delle maggiori imprese generali di costruzioni italiane, ha curato la realizzazione di importanti opere di ingegneria industriale e civile in Puglia e Basilicata (centrale Enel di Brindisi Sud, numerose centrali telefoniche, centri di meccanizzazione postale, nuova chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, ecc.). È stato Consigliere di amministrazione di Tecnopolis Novus Ortus e del Centro Laser di Bari. Dal 2014 al 2016 è stato Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese Spa, e dal 2017 al 2021 Presidente del Consiglio di amministrazione di Retegas Bari. Attualmente è componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
made in Italy, donald trump, dazi