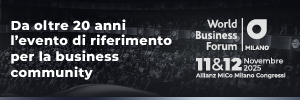Follow the money: c’è un’etica anche nell’inseguire il guadagno
La prima regola per il tifoso è che la maglia è una fede. Peccato che la stessa cosa valga sempre meno di frequente per i giocatori e gli allenatori. Sono ormai rari i calciatori fedelissimi di una squadra. L’ultimo è stato forse Francesco Totti, che ha rifiutato, durante la sua carriera, numerose offerte economiche, anche di fronte a delusioni cocenti, pur di restare alla Roma (che comunque gli ha corrisposto ingaggi milionari). E per questo è considerato l’ottavo re: riconoscimento che gli è sempre stato rivolto anche dagli avversari.
Recentemente abbiamo assistito al caso Donnarumma. Questi è un talento precocissimo del mondo del pallone: a soli 14 anni, durante gli allenamenti nella sua città natale (Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli) fu notato dal Milan, che acquistò il portiere per 250mila euro, cifra record per un adolescente. A soli 16 anni l’esordio in Serie A in quella che, già da bambino, era la sua squadra del cuore. Da lì, il passo verso la Nazionale è stato breve.
Chi immaginava per il giocatore un lungo matrimonio con la maglia rossonera è restato deluso, perché le cose sono andate diversamente: la società non ha accettato le ennesime condizioni economiche richieste (ritocco al rialzo di milioni di euro) e così il rapporto di lavoro si è concluso. Il risultato è che su media e web si è svolto il ‘processo’ a Donnarumma, con i tifosi del Milan, furenti per l’accaduto, che hanno parlato di mancanza di etica da parte del portiere, rispolverando casi di giocatori che pur di restare alla corte del Diavolo hanno firmato contratti in bianco (per esempio l’ex capitano rossonero Franco Baresi).
Ma chi lo dice che ricercare maggiore guadagno per sé – e per la propria famiglia – sia non etico? Chiara Berti, consulente aziendale e docente in Management e Marketing presso l’Alma Mater Studiorum– Università degli studi di Bologna spiega: “Il tema vero è che il calcio professionistico, ormai, non è più uno sport, ma un business”. Ecco perché, secondo Berti, gli aspetti etici che, tradizionalmente, accompagnano la pratica sportiva e la competizione agonistica faticano a emergere nel mondo del pallone. E nel caso in questione, per l’esperta il ‘gran rifiuto’ è stata una scelta coraggiosa del club, soprattutto nel frangente di grave crisi che stiamo attraversando.
Superata la soglia willingness to pay
In ogni caso, la vicenda ha reso evidente agli occhi di tutti quanto, ormai, i manager influenzino le decisioni dei calciatori e il mercato relativo, proprio come se fossimo di fronte a qualunque altra trattativa, relativa alla compravendita di un bene prezioso. Infatti, Donnarumma si è affidato, sin dagli esordi, a uno dei procuratori più determinati al mondo: Mino Raiola. Questi è stato così abile da sfruttare un’opportunità unica, data dalla giovane età del suo protetto: fino a che i calciatori sono minorenni, non è loro consentito stipulare contratti che non siano di durata annuale. Ma anche compiuti i 18 anni, Raiola ha continuato a rinnovare gli impegni per brevi periodi. Questo ha fatto sì non solo di poter rinegoziare lo stipendio del calciatore con maggiore frequenza, ma anche di non vincolare il cartellino.
Come spiega Berti, il cartellino segna, in qualche modo, un’appartenenza; perdere un calciatore a parametro zero per la società che l’ha cresciuto è – oltre al danno affettivo su cui hanno puntato i tifosi – un danno economico estremamente rilevante. Inoltre, c’è da considerare un altro aspetto negoziale correlato: il procuratore chiederà commissioni personali molto più elevate al futuro club acquirente del calciatore, proprio perché il calciatore non porta in dote il prezzo del cartellino. Questo significa che Raiola è, in fondo, un bravo professionista: è riuscito a ottenere il massimo, almeno dal punto di vista economico, per sé e per il suo cliente.
A corollario di tutto ciò si aggiunge la valutazione del fatto che il Milan da diversi anni ha perso smalto a livello europeo e anche questa ‘debolezza’ avrebbe potuto contribuire, nel tempo, a svalutare il ‘prodotto’ Donnarumma. Ciò che è successo, dunque, è stata una valutazione puramente razionale e d’affari, che non ha nulla a che fare con la passione dei tifosi.
È avvenuto, dunque, quello che succede in qualsiasi rapporto di mercato. Semplicemente, con il Milan è stata superata la cosiddetta willingness to pay, cioè quella soglia psicologica che stabilisce il prezzo massimo che il consumatore è disposto a pagare per un bene. Come spiega Berti, questo è un concetto chiave per definire l’efficacia di una strategia di prezzo. Essa varia in funzione di diversi fattori, dalla qualità del prodotto, alla sua disponibilità, all’offerta della concorrenza: insomma, niente a che vedere con l’etica.
Lo sport è (anche) business
In fondo, nel marketing ci sono aspetti emotivi che pesano quanto il business. Una delle testimonianze più eclatanti arriva dall’Oriente; negli ultimi anni molti calciatori europei avevano scelto di andare a giocare nello sconosciuto campionato cinese, richiamati da ingaggi faraonici, sulla spinta delle strategie di Stato cinesi, che miravano a una espansione mondiale in questo sport. Bolla che è recentemente esplosa per cambio di strategia governativa.
In generale, tutto lo sport professionistico rema sempre più nella direzione del business. E nelle aziende avviene ormai la stessa cosa. Le generazioni precedenti percepivano molto di più l’engagement, lavorando spesso tutta la vita per la stessa società, considerata quasi una seconda famiglia. Anche il paternalismo aziendale aveva certamente aspetti negativi. Ora, tuttavia, non di rado capita di vedere impiegati e commerciali che hanno frequenti rapporti con i competitor, in un ambiente paradossalmente meno competitivo e più collaborativo. “Sin dal momento della firma sul contratto, un dipendente o un collaboratore non esclude più che, un domani, potrebbe decidere di andare a lavorare per la concorrenza. Dunque, meglio mantenere buoni rapporti con tutti”, osserva sorridendo Berti.
L’esperta fa notare come, spesso, proprio per tutelarsi, le aziende inseriscono nei contratti per i ruoli apicali le clausole di non concorrenza, con penali anche molto ingenti: più raramente, però, questo avviene per le qualifiche gerarchicamente sottostanti. “Chi dice che fa più danno a un’impresa il ‘tradimento’ di un solo top manager, rispetto a quello di una dozzina – o più – di posizioni intermedie, che cambiano più frequentemente impiego?”, si chiede Berti.
Tuttavia, questa discussione è ‘molto italiana’, secondo la docente, che ha esperienza di studio e lavoro all’estero: “Nelle big corporation, per esempio, è normale cambiare lavoro con frequenza, per motivi economici. Ed è normale anche un altro fenomeno: segnalare colleghi considerati di valore. In Italia, sussiste solo il lato negativo della questione: le assunzioni per ‘raccomandazione’ demotivano il personale. Non si creano, così, quei circoli competitivi virtuosi, che portano alla crescita dell’azienda”. Anche i manager hanno delle responsabilità, quanto all’engagement dei dipendenti: se non funziona il vertice, la base arranca. Dunque, conclude Berti, quello che accade nel calcio avviene al pari di quanto accade in altre forme organizzative come quella aziendale: “Ci stiamo abituando e non possiamo dire se questo sia un bene o un male”.
Ecco perché etichettare la vicenda di Donnarumma solo facendo riferimento ai valori aziendali e all’irriconoscenza del giocatore è quanto meno riduttivo. Il giovane portiere sarà più felice con qualche milione di euro aggiuntivo in tasca? Non spetta a noi stabilirlo. Di certo etica e business non devono per forza essere in contrasto. Il vero problema è condividere che cosa si celi dietro il termine “etica” e come questa si concili con gli affari, per evitare un eccesso di relativismo. Le aziende – in questo caso il club di calcio – hanno grandi responsabilità: le leve di ingaggio e di fidelizzazione possono essere successive al confronto sull’etica, così almeno da condividere i valori di base. E in un mercato nel quale le concorrenza è sempre più ardita, potrebbe essere il modo per non farsi schiacciare dal relativismo dell’etica.
Bolognese, giornalista dal 2012, Chiara Pazzaglia ha sempre fatto della scrittura un mestiere. Laureata in Filosofia con il massimo dei voti all’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, Baccelliera presso l’Università San Tommaso D’Aquino di Roma, ha all’attivo numerosi master e corsi di specializzazione, tra cui quello in Fundraising conseguito a Forlì e quello in Leadership femminile al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Corrispondente per Bologna del quotidiano Avvenire, ricopre il ruolo di addetta stampa presso le Acli provinciali di Bologna, ente di Terzo Settore in cui riveste anche incarichi associativi. Ha pubblicato due libri per la casa editrice Franco Angeli, sul tema delle migrazioni e della sociologia del lavoro. Collabora con diverse testate nazionali, per cui si occupa specialmente di economia, di welfare, di lavoro e di politica.
etica, business, concorrenza, Donnarumma