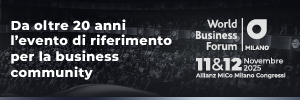Decreto Omnibus e sostenibilità, l’Ue ha scelto il dietrofront?
Il 26 febbraio 2025, in perfetto tempismo rispetto a quanto annunciato a gennaio, la Commissione europea ha pubblicato il cosiddetto “Pacchetto Omnibus” (Omnibus I, “Semplificare le norme dell’Unione europea e stimolare la competitività”, e Omnibus II, “InvestEu e Unione europea”). Si è trattato di un forte segnale normativo sollecitato da differenti attori, Stati membri, Governi e imprese con un unico obiettivo: semplificare un sistema di regole che potrebbero creare (o meglio, avrebbero potuto creare) conseguenze fortemente negative per il business dell’Ue, penalizzando le imprese in termini di competitività a livello globale.
Si torna quindi a un grande dubbio amletico: “Essere o non essere sostenibili?”. Tale interrogativo rappresenta quindi, ancora oggi, un tema da risolvere per il business for profit. Intraprendere un percorso orientato ai fattori ESG può rappresentare una minaccia per la competitività e il successo aziendale? È ancora interpretato solo come un costo e un dispendio inutile di risorse? Da come è impostato il pacchetto Omnibus sembrerebbe proprio di sì.
Deregolamentato l’impianto normativo
In realtà, su tale aspetto sembrava ormai esserci una pressoché unanime condivisione: il contesto imprenditoriale, per lo meno quello caratterizzato da imprese di medie-grandi dimensioni, stava iniziando a muoversi in questa direzione, nella convinzione che effettivamente la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder, compreso il nostro Pianeta, potesse effettivamente apportare benefici, anche di carattere economico-finanziario, in termini di incremento della performance e quindi anche di crescita del sistema economico.
Il campanello d’allarme del Pacchetto Omnibus sembra invece affermare il contrario, addirittura capovolgendo l’impostazione precedente: sovverte e, come molti esperti e operatori del settore sostengono, ‘deregolamenta’ un impianto normativo molto ambizioso, risultato di molteplici sforzi compiuti dalla Commissione europea in termini di risorse impiegate, iniziato ormai da più di 10 anni con la prima Direttiva non-financial reporting (Nfrd) nel 2014 e con la sua successiva implementazione negli Stati membri dal 2017 (Non-financial reporting disclosure Ue 95/2014). In sintesi, ripercorriamo gli aspetti più rilevanti, premettendo che si tratta ancora di una proposta e che sarà soggetta a modifiche e/o integrazioni da vari co-Legislatori prima della sua definitiva approvazione in Ue, per poi dover essere recepita dai vari Stati membri.
Una Direttiva sulla buona strada
“Stop the clock” è la sorta di slogan con cui la Commissione europea ha annunciato una nuova fase nell’applicazione della Direttiva Ue 2022/2464, nota come Corporate sustainability reporting directive (Csrd), recepita in Italia tramite il D.lgs 125/2024, emanato a settembre 2024. Tale Direttiva, che aggiorna e rivede la precedente Nfrd Ue 95/2014, è entrata ufficialmente in vigore nel 2023, prevedendo un rilevante aumento delle imprese soggette agli obblighi della rendicontazione di sostenibilità. L’ampliamento dell’ambito applicativo consente di individuare sostanzialmente quattro categorie di imprese: Wave 1, Wave 2, Wave 3 e Wave 4.
La prima categoria raggruppa le grandi aziende Enti di interesse pubblico (Eip): si tratta di realtà aziendali (essenzialmente società quotate, banche e assicurazioni) con più di 500 dipendenti medi annui, che superano alternativamente i due limiti dimensionali del fatturato netto (oltre 50 milioni di euro) o del patrimonio netto (oltre 25 milioni di euro).
La seconda comprende grandi società quotate e non (è abbandonato il requisito dell’Eip) che superano due dei tre criteri dimensionali: 250 dipendenti in media all’anno e gli stessi requisiti indicati per la precedente categoria relativamente al fatturato netto e al patrimonio netto. La differenza sostanziale è che i tre requisiti dimensionali sono messi sullo stesso piano.
La terza categoria, invece, raggruppa le Piccole e medie imprese (PMI) quotate che sono obbligate alla rendicontazione, sempre che siano quotate sui mercati regolamentati. Nella quarta e ultima categoria, infine, rientrano i gruppi societari al di fuori dell’Ue che hanno generato nell’unione ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e dei quali almeno un’impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della Csrd o una succursale (presenza fisica) ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.
In sostanza, con lo “Stop the clock” la Commissione europea ha manifestato la volontà di rinviare l’applicazione iniziale della Csrd per le imprese della Wave 2 e Wave 3 di due anni. È inoltre imposta una particolare urgenza in quanto tale rinvio dovrà essere recepito da parte degli Stati membri entro la fine del 2025, mediante la procedura d’urgenza. La possibilità per i soggetti che sarebbero obbligati a pubblicare il report di sostenibilità in base alla Csrd di avere due anni di tempo in più rispetto alla tempistica vigente rappresenta senz’altro una rilevante opportunità, ma gli effetti dell’Omnibus vanno oltre…
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)
PhD, Professore Associato di Economia Aziendale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
sostenibilità, ESG, Decreto Omnibus