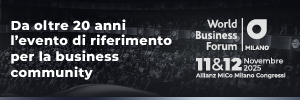Riformare l’istruzione tecnica è un dovere sociale
Sull’istruzione tecnica, i nodi iniziano a venire al pettine? L’ammontare delle risorse finanziarie destinate alle riforme sta generando attrattività e producendo i risultati aspettati? Sono domande legittime che introducono un po’ sbrigativamente il concetto, non sempre familiare, delle ‘rendicontazioni’, delle iniziative che servono a ‘produrre futuro’ al Paese, con l’impiego di somme ingenti che, per l’economia e la situazione debitoria in cui ci troviamo, andrebbero gestite con grande grano salis.
Occupandoci di politiche scolastiche, l’importanza della misurazione dell’efficacia dei risultati prodotti, e semmai le correzioni di rotta qualora fossero necessarie, dovrebbero già appartenere alla cultura della scuola – nel learning by doing e, ancor di più, nel learning by mistakes – e quindi anche all’istruzione tecnica, quel settore importante dell’ordinamento scolastico verso cui sono indirizzate le nostre attenzioni, che ha un’incidenza enorme sulla politica economica industriale e del lavoro del nostro Paese e che ha anche lo scopo di crearne la classe dirigente.
Mario Draghi, di fronte alle ingenti cifre da spendere con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ebbe più volte a raccomandare che questi soldi fossero gestiti come ‘debito buono’ e non come spese senza alcuna verifica dei benefici tangibili del ritorno economico dell’investimento fatto. Il concetto in sé è elementare. Il Pnrr dispone, a parere di molti, di una quantità anche eccessiva di risorse finanziarie, che sono soldi presi a debito, i cui costi incidono sui nostri bilanci, così come il capitale da restituire, che è una componente della preoccupante cifra totale del nostro debito pubblico di cui se ne dovranno fare carico le prossime generazioni. Un debito buono è invece un investimento che deve produrre dei risultati valorizzabili anche in concreti ritorni economici, che tra l’altro dovrebbero essere trasparenti e attentamente monitorati e resi pubblici. Per i tanti soldi del Pnrr spesi per la scuola – a partire dall’istruzione tecnica, compresi gli Its, ma anche gli ingenti finanziamenti per l’orientamento – c’è da chiedersi quale rendicontazione sia prevista che possa attestare la ‘bontà’ del debito, a partire da un accurato calcolo del suo return, meglio definito come Return on investment (ROI) o, nello specifico, il Return on qualification (ROQ), così come è indicato nella letteratura degli investimenti in materia di politica scolastica.
Nel saggio che ho pubblicato un anno fa, dal titolo Ricostruire l’istruzione tecnica. Ultima chiamata per rimanere la seconda manifattura in Europa, salvare la nostra economia e preservare il nostro welfare, ho dedicato un paragrafo apposito all’argomento, dal titolo: “Debito buono: il calcolo del ritorno sugli investimenti”. Nel testo ho illustrato il sistema degli indicatori principali che misurano l’effetto di un investimento finanziario nelle politiche scolastiche attraverso l’incremento della qualità del sistema d’istruzione, il suo impatto sull’economia, l’impatto sull’occupazione e sul welfare e l’impatto sulla creazione di un sistema sostenibile attraverso qualificate partnership. Già il titolo del saggio citato evidenziava l’assoluta urgenza di occuparsi di un argomento assai importante per il nostro Paese, che andava ben oltre la fattispecie di una necessaria riforma scolastica. Più volte ho indicato che, per occuparsene, occorra un ministero dedicato, con ampie competenze anche nel settore dello sviluppo economico e delle politiche del lavoro e del welfare, anziché il Ministero dell’Istruzione e del Merito, i cui ambiti di competenza sono assai limitati.
Un problema da affrontare urgentemente
È la ragione per cui ho indicato più volte che il tema dell’istruzione tecnica, derivante dalla grande mancanza dei tecnici, vada affrontato con un’incisiva rivoluzione copernicana attraverso un grande progetto di turn around nato dagli Stati generali, anziché con l’attivazione di singole o plurime iniziative di manutenzione dell’esistente, senza nessun approccio sistemico, ma con ‘avanzamenti a impulsi’ principalmente promossi dalla contingenza della mancanza dei tecnici per le nostre aziende. Ciò è conseguenza di una politica di risposta ai bisogni reattiva, di tipo pull, che omette l’approccio di tipo push, il quale avrebbe richiesto un’adeguata visione di sistema, oltre gli orizzonti attuali.
Il problema della mancanza delle professioni tecniche di cui avrebbe bisogno il Paese è innanzitutto multidimensionale e assai più complesso di quanto si è cercato di rappresentare con i bisogni espressi dalle contingenze del momento; e, laddove si iniziasse a prendere evidenza degli esiti delle iniziative messe in campo per valutarne i risultati, è probabile che le informazioni di ritorno sarebbero già infarcite dalle criticità del sistema, quelle che, con semplificazioni, si potrebbero addirittura chiamare i nodi irrisolti che stanno venendo al pettine e che avrebbero bisogno di essere presi in considerazione con delle radicali misure correttive.
Il punto da cui partire è sempre il valore strategico che assume l’istruzione tecnica, nella sua definizione più ampia, che deve comprendere l’istruzione terziaria e anche l’istruzione professionale. Un sistema eccellente di istruzione tecnica può essere una delle leve importanti per affrontare le sfide del nostro sistema industriale e ancor di più oggi, per sostenere la crescita delle nostre imprese, la crescita dell’occupazione con contratti e politiche salariali adeguati e non basati sull’indeterminatezza e precarietà. Queste ultime sono le principali cause di una sottoccupazione improduttiva e della migrazione, alla ricerca di buone prospettive lavorative, dei nostri migliori giovani.
In più, una buona istruzione tecnica è necessaria per introdurre nel mercato del lavoro dei tecnici ben preparati per sostenere il nostro welfare e, in particolare, il sistema previdenziale che ha bisogno di tanti lavoratori, almeno il 10% in più degli attuali per allinearsi ai valori occupazionali europei, con buoni stipendi. Così come un adeguato sistema di istruzione tecnica, se inserito in un’intelligente politica commerciale estera di cooperazione allo sviluppo, potrebbe ben aiutare a modulare e valorizzare l’attuale emigrazione economica, prendendo in considerazione le opportunità offerte da quei Paesi che hanno ancora crescita demografica e che, potenzialmente, potrebbero essere i destinatari di un nuovo export delle nostre imprese, a partire dal machinery del Made in Italy.
Perito elettronico e laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, è Maestro del Lavoro. Le prime esperienze lavorative sono nel campo dei sistemi di controllo. Nello stesso periodo, per nove anni, è anche docente di elettronica industriale presso un importante istituto tecnico serale. Contemporaneamente inizia la sua attività presso una società di un gruppo tedesco, leader mondiale nella componentistica per l’automazione industriale nonché partner del governo della Germania per la costruzione del modello duale della formazione professionale. Successivamente diventa Direttore Generale e Amministratore Delegato di una nuova società del gruppo che si occupa di consulenza strategica e operativa nelle aziende industriali a cui appartiene una scuola di Industrial Management e una divisione per i sistemi di apprendimento. È stato pioniere delle prime iniziative di formazione applicata superiore nazionali e transnazionali. Ha intrattenuto rapporti con molti istituti tecnici e istituzioni pubbliche ed è stato promotore e attore di iniziative riguardanti l’evoluzione delle professioni tecniche. Ha terminato la sua attività professionale nella posizione di Vice President del gruppo internazionale, per il settore della Global Education, occupandosi dell’interconnessione tra economia e mercato del lavoro per la progettazione e realizzazione di sistemi TVET per governi di Paesi in via di sviluppo.
Pnrr, istruzione tecnica, stati generale