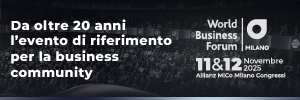Tornare a narrare buone storie di partecipazione attiva
Le imprese dovrebbero riacquisire la capacità di raccontarsi per non sprecare l’opportunità di un vero cambiamento.
Le esperienze vissute, tanto più se traumatiche, hanno bisogno di trovare posto in un contesto che consenta, alle persone che dovranno farci i conti, la possibilità di interpretarle, condividerle e ricavarne una direzione come orientamento per comportamenti futuri. Senza memoria dell’accaduto e delle sue ricadute pratiche, il passato, una volta ingoiato dalla velocità dei cambiamenti contemporanei, non avrà più alcun significato né riuscirà a fornire, anche per contrasto, indicazioni utili su ciò che sarebbe più necessario per non essere lasciati soli di fronte all’imprevedibile.
Nessun evento diventa patrimonio di conoscenza, e del sentimento di spinta verso un’evoluzione che in genere l’accompagna, se rimane orfano di un racconto che lo comunichi come una ‘storia’ dotata di senso. Una ‘storia’ accaduta e vissuta per essere ricordata e perciò tale da garantirci identità e potere negoziale nel collocare le nostre memorie singole, aprirle a relazioni più vaste, usarle come sapere, forse anche opinabile, ma sempre comunque vissuto come parte viva di noi stessi. E così il ciclo: storia, memoria dell’esperienza, racconto e narrazione, è quello che consente l’unica forma di comunicazione socialmente spendibile per affrontare collettivamente la complessità degli eventi con cui un gruppo, una comunità, un’impresa è destinata a confrontarsi nei momenti di difficoltà.
Il rischio tende ad aggregare gli interessi e le disponibilità delle persone per ridurre il perdurare delle difficoltà nelle situazioni avverse. Ma se non scatta la creazione di un contesto ‘accogliente’ che sia in grado di elaborarlo all’interno di una memoria condivisa, è facile che poi sopravvivano le stesse regole e gli stessi modelli che hanno impedito di prevederlo per tempo. E, così, a riproporre il disagio tornando esattamente a quello che non è servito.
La storia per avere più sicurezza in futuro
Se proviamo a guardare a quello che l’esperienza traumatica di questi mesi ha messo in gioco, nelle relazioni organizzative e nell’immaginario delle persone, non possiamo pensare di uscirne indenni semplicemente utilizzando le forme consuete di comunicazione. Anche fossero quelle che annunciano cambiamenti epocali nei sistemi utilizzati per governare comunità di impiego, imprese più o meno grandi, o aggregati di risorse di qualsiasi tipo orientate su degli obiettivi vincolanti, sarebbero comunque parte di un mondo che la profondità della crisi ha reso ormai inadeguato.
Una comunità, un gruppo, una società, specie di fronte all’emergenza che ne mette in discussione gli assetti tradizionali e la distribuzione interna dei poteri (cosa che è abbondantemente accaduta in questo scorcio d’anni) non ha alcuna possibilità di chiarire le sue ragioni o di supplire al deficit di cultura dell’emergenza (che l’ha vista prendere frettolosamente decisioni che sconvolgono apparentemente la sua organizzazione), senza essere in grado di raccontare tutto come una storia vissuta consapevolmente. Una storia, però, che offra alle persone la prospettiva di una ‘abitazione’ diversa da quella che non ha retto l’impatto esterno e offra maggiori condizioni di sicurezza in prospettiva.
È solo la possibilità di avere un racconto credibile che consente di fornire il destro per una narrazione in grado di collocare la storia che si vive come patrimonio di tutti, e a questa di ‘risuonare’ collettivamente, così da legittimare l’apertura di un confronto tra soluzioni preconfezionate e aspettative più aderenti alla necessità di innovare. Ciò che entra come tessuto della storia – e diventa parte determinante della sua trama – sono allora tutti i soggetti presenti coinvolti come attori nei processi che si sono messi in movimento: gente che ‘ha preso voce’, che può portare finalmente il contenuto della propria esperienza, ma anche delle emozioni, delle paure, delle decisioni pratiche che l’hanno accompagnata durante la fase più acuta e confusa della crisi.
Bisogna essere in grado di raccontarsi perché quello che abbiamo vissuto acquisisca un senso utilizzabile nel disegnare ‘il nuovo’ di cui non possiamo fare più a meno. E anche perché ciò che si è vissuto da protagonisti recuperi rispetto e dignità. È solo la narrazione condivisa che rende ‘abitabile’ l’esperienza fatta e chiarisce i cambiamenti inevitabili, così che le nuove forme organizzative risultino poi essere per tutti una ‘dimora’ più adeguata sia per le aspirazioni maturate sia per l’efficacia dei processi testati come realizzabili.
Lo storytelling che funziona non nasce per caso
Ora, non c’è chi non si renda conto che una storia aziendale capace di sollevare emozioni e generare poi passioni orientate alla sua continuazione, non è operazione che si possa montare a tavolino, con tecniche ormai usurate, e magari la presunzione che uno storytelling ben confezionato sia in grado di convogliare le persone verso una identificazione collettiva.
Purtroppo –o per fortuna– le storie non nascono dal niente; hanno bisogno, per funzionare, di accadimenti che segnano profondamente la vita di coloro che da questi eventi vengono toccati, sviluppano culture e linguaggi site specific, non consentono indifferenza o distinguo. Sono tali perché ‘prendono’ e catturano anima e immaginario, tanto che uno finisce con l’identificarsi e trovare quasi inevitabile vivere in esse.
È stato così delle storie (poche, purtroppo) che hanno caratterizzato lo sviluppo del Paese in una certa fase storica, per alcuni versi assimilabile: l’Eni di Enrico Mattei, l’Olivetti di Adriano Olivetti, la Comit di Raffaele Mattioli, la Casmez (Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia Meridionale) di Pasquale Saraceno (fino alla fine degli Anni 60) e, collegata, lo Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno).
E poi ancora la Pirelli di Leopoldo Pirelli e l’Iri del Dopoguerra, quella dei ‘boiardi competenti’. Le storie hanno bisogno, per innestarsi con premesse robuste così da poter durare, di contesti esterni sfidanti. Con i quali non si viene a patti senza saper rischiare, trovando il coraggio di spostarsi sui confini delle proprie zone conosciute, laddove le certezze tremano e nulla è detto che sia come è sempre stato.
Avere a disposizione un futuro, a quei tempi – tra la fine della guerra e i primi Anni 60 – faceva sì che aspirazioni e progetti creassero un orizzonte delle attese in cui era facile credere se ci si impegnava. In fondo, c’era potenzialmente un posto per tutti nella narrazione che accompagnava la crescita, ed era una tessitura socialmente partecipata quella che reggeva lo sforzo collettivo di un’intera comunità nazionale: collocarsi in una posizione tale da rendere possibile quello che nasceva come semplice speranza.
Poi lo slancio si è prima attenuato e, via via, è quasi svanito; tutto è diventato competizione su un presente sempre più ingombro e asfittico. Gli attori sociali, un tempo in grado di riconoscersi reciprocamente come indispensabili, hanno perso gran parte delle loro componenti esplorative e del loro linguaggio pubblico. Si sono dedicati alla pratica funambolica del ‘durare’: un esercizio di nessuna rilevanza simbolica che non fosse quella del ripiegamento orientato a preservarsi. E così gli interessi hanno monopolizzato piccoli universi privatizzabili a piacere, a tutela di logiche sempre più partigiane.
La politica –quella cattiva e la mediocrità dei suoi interpreti– ha poi fatto il resto, con la morte della civiltà del confronto e il prevalere di una logica amico-nemico che non prevedeva prigionieri. Le aziende, per parte loro, sempre più strette in una concorrenza mondiale e con scarsissimi supporti in patria, hanno cercato di fronteggiare le crisi ricorrenti serrando i ranghi con supplementi di devozione al metodo e a una razionalità iper-procedurale, che offriva spazio e gloria ai guru della consulenza e preparava la scomparsa, o il destino di irrilevanza, alle più grandi tra di esse.
Come costruire una storia spendibile, e in grado di prendere il cuore oltre che i curricoli delle persone, nella povertà crescente delle elaborazioni culturali incapaci di offrire vie di fuga dall’asfissia del quotidiano? Sono seguite generazioni senza ancoraggi, fatte più di mode ricorrenti, e di ricerca di carriere esemplari nel loro exploit, che di attenzione alle fratture che si stavano generando nel corpo sociale dell’impresa. È qui, nel tessuto che si veniva progressivamente usurando, che le avventure professionali sono diventate un inseguimento a poteri remunerati – e ripetibili – che lasciavano per strada larga parte dei ‘senza destino’. Nessuna storia possibile in assenza di passioni collettive e di condivisione di un’ipotesi di futuro che tenesse dentro tutti.
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)
Pier Luigi Celli è nato a Verucchio (Rimini) l’8 luglio 1942. Sposato con Marina, ha due figli. Laureatosi in Sociologia all’Università di Trento, ha maturato significative esperienze come Responsabile della Gestione, Organizzazione e Formazione delle Risorse Umane in grandi gruppi, quali Eni, Rai, Omnitel, Olivetti ed Enel. Il bagaglio manageriale acquisito nella gestione di grandi aziende con business così complessi e diversificati, gli ha permesso nel 1998 di tornare in Rai come Direttore Generale.
Dopo aver ricoperto ruoli fondamentali nello startup di nuove attività per la telefonia mobile – Wind e Omnitel – è stato, per un breve periodo, alla guida di Ipse 2000, società di telefonia per l’Umts. Dal 2002 ad aprile 2005 ha lavorato in Unicredito Italiano, come Responsabile della Direzione Corporate Identity, con la missione di dare un’identità a un gruppo che negli ultimi anni ha aggregato sette realtà in Italia e cinque all’estero.
Da maggio 2005 a luglio 2013 ha lavorato all’Università Luiss Guido Carli come Direttore Generale e dal 2013 a giugno 2014 in Unipol come Senior Advisor Corporate Identity, Comunicazione
e Relazioni Istituzionali. Ha ricoperto la carica di Presidente dell’Enit da maggio 2012 a giugno 2014 e dal 2014 al 2016 ha ricoperto in Poste Italiane il ruolo di Senior Advisor dell’Amministratore Delegato.
Oggi è Presidente di Sensemakers, società che offre servizi di consulenza e prodotti in ambito digital basati su Big data e Analytics.
cambiamento, futuro, storie, storie di impresa